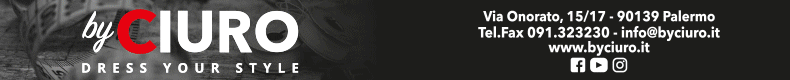Sono passati 70 anni, che sembrano tanti ma, a farci caso, non sono neanche una virgola nella storia della terra. I soldati dell’Armata Russa il 27 gennaio del 1945 entravano ad Auschwitz svelando al mondo, con le loro foto, un orrore già conosciuto e sofferto da milioni di persone. I campi di concentramento nazisti.
Era la fine della guerra più vigliacca e disumana della intera storia della civiltà.
Da allora ogni anno ricordiamo il sacrificio di milioni di fratelli morti per la lucida follia della razza. Da allora, ogni anno, dimentichiamo un’altra storia, a noi più vicina e forse per questo più dolorosa.
E’ la storia dei militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi.
600 mila soldati di cui ancora oggi nessuno sa dire quanti siano sopravvissuti e quanti invece siano rimasti vittima della stessa follia della Shoah. La storia non si è mai occupata di loro. Hanno avuto la colpa di essere stati chiamati alle armi dall’esercito sbagliato. Nessuna pietà per loro.
Ma la volontà che spinse centinaia di miglia di soldati italiani ad affrontare un destino che si presentava sotto i più infausti auspici, invece di cedere alle lusinghe dei tedeschi, rappresenta il più vasto fenomeno di opposizione al regime che la storia si rifiuta di ricordare.
Fu resistenza anche questa, e pagata a caro prezzo. Per ricordarla, per ricordare il sangue di questi eroi, proponiamo qui di seguito un documento inedito. Lo stralcio di un diario di guerra tenuto da un bersagliere italiano di 20 anni, chiamato alle armi ed inviato sul fronte jugoslavo a combattere contro i partigiani di Tito e poi, dopo l’armistizio, contro di loro, contro i tedeschi e contro i pochi militari italiani rimasti fedeli al regime. Una caccia spietata di migliaia di soldati contro una manciata di ufficiali e sotto ufficiali, senza armi ne cibo, che finì come doveva finire: 2 anni di prigioni fra campi di lavoro e miniere di carbone. Fra questi anche 3 madoniti, tutti di Gangi: i soldati Ferraro, Manto e Mantegna. Ecco cosa patirono:
La pineta di Monte Mariano a Spalato è una vasta ed immensa cupola di verde. Centinaia di alberi, ora radi ed ora fitti, a gruppi o a filari, si arrampicano svogliati su per le dolci pendici della collina. La spiaggia di “Spinut”, sassosa, irta, scoscesa, s’imbianca, ai suoi piedi, di sfuggenti merlettature di schiuma.
Circa ventimila soldati, d’ogni arma, dopo la resa ai partigiani, vanno in cerca d’uno posto qualsiasi, ove passare, nell’ansia dell’attesa, i giorni che, dopo l’otto settembre, sono diventati appunto come la risacca del mare che va e viene, risospinta e attratta dalla spiaggia in monotona altalena e con lamentosa voce.
Su un quotidiano di Spalato di qualche giorno fa mi capita sott’occhio un mio articolo “nostalgia di Sicilia”. Non ho la forza di leggerlo, preferisco ridurlo a pezzetti che abbandono al vento. Volano i pezzi di carta nell’aria, ma presto si riposano a terra come foglie morte: avvizzite speranze!
Nel cielo un aereo tedesco gironzola e pare vada a spasso per i fatti suoi. Si abbassa. Sfiora ora le cime dei pini con un rumore assordante che fa venir la pelle d’oca. Piovono dei manifestini: “Italiani, sappiamo che ormai siete disarmati. Ma la guerra continua. L’arresa di Badoglio non conta. Noi siamo ancora in armi con la volontà tesa verso la vittoria …” E via di questo passo.
Continui o non continui, la guerra per noi è finita. Non abbiamo più armi, non abbiamo più capi e soprattutto non abbiamo più speranza. Il Cappellano militare, su un altare improvvisato all’aperto, sotto l’ombrello di un pino, celebra la Messa. Il Mare mormora in basso. Un soffio di vento, a volta a volta, zufola fra i rami. Ma tutto il resto è silenzio. Le parole del Cappellano poi risuonano e si disperdono nell’aria: “Solo Iddio può salvarci!”
Lungo la spiaggia brulicano migliaia di soldati. Alcuni sono già all’opera per costruire delle zattere su cui evadere. Altri a cuocere nella gavetta un po’ di pasta “arrangiata” nei magazzini aperti dagli slavi.
Un rombo sempre più insistente si avanza. Trenta Stukas tedeschi sono sopra la nostra testa. Getteranno i soliti manifestini? Ma non c’è il tempo di chiederselo e fitte raffiche di mitragliatrici si alternano a grappoli di bombe. Per circa quaranta minuti è un inferno. Fragore. Fiamme. Polvere. Grida. Rantoli. Invocazioni. Lamenti … Mi rifugio tra poche pietre nella spiaggia. Son con me due commilitoni. L’uno prega. L’altro, giovanissimo, invoca la madre. Il mare, indifferente, si avvicina a noi, ci lambisce, si ritrae, quasi anch’esso atterrito. Molti si buttano in mare cercando di allontanarsi a nuoto. Ma gli apparecchi li inseguono. L’urlo del motore sembra esca dalle acque che si colorano di larghe chiazze di sangue.
Vanno via! Non è vero. Un aereo rivola ora proprio su di noi. Si abbassa. Si innalza. Si allontana? (Un respiro). No, ritorna. Cinque bombe scendono fischiando. E’ un minuto, ci si stringe forte la testa fra le mani. Un boato: assordante ed accecante. La terra si rovescia su di noi. Ci seppellisce. Ma siamo vivi … vivi! Il sangue, lo sento, pulsa ancora nel cuore, nelle vene, alle tempie. Sono vivo, mio Dio, sono vivo!”
Ma lo spettacolo che ora ci si presenta è orribile. Morti dovunque. Brandelli di carne. Divise inzuppate di sangue. Per molti di loro non c’è più nulla da fare, si cerca di dare aiuto ai feriti ma il rombo degli aerei si rifà vicino. Ritornano? Forse ritornano? Ma perché? Che cosa hanno contro di noi? Non sanno che siamo disarmati? Uomini di nessuno! Senza possibilità di difenderci e tantomeno di offendere. Di che ci vogliono punire? Forse di aver consegnato ai guerriglieri le nostre armi?
Il bilancio è doloroso. Più di mille fra morti e feriti. Mille uomini che fino a qualche ora fa si aggiravano sulla spiaggia o fra gli alberi della pineta lottando solo con se stessi perché la speranza resistesse, non morisse e fosse di aiuto nell’attesa, giacciono ora riversi e sanguinanti. Inutilmente i raggi del sole, battendo sui loro volti, cercano di accendere le pupille ormai prive di luce.
Si raccolgono catenine e lettera. Pietà per chi muore, pietà per chi vive, ancora, nell’attesa che è anch’essa una morte lenta. Ma la pietà non esiste più in questo ultimo scorcio di guerra. Si è diventati, non si sa perché, più crudeli, più inumani, più barbari. L’amore è solo una parola. Tutta una civiltà vacilla.
Mentre sanguinano le carni dei morti e dei morenti, i cannoni continuano a tuonare, gli aerei a rombare, le mitragliatrici a gracidare.
C’è chi ormai, per risentimento si arruola e corre a ingrossare le fila dei “garibaldini” di Tito che combattono sui monti. Io no. Non intendo andare. Non intendo riabbracciare una fucile. Non intendo più combattere; pur se i partigiani ora cominciano a sorriderci perché oltre alle nostre armi, hanno bisogno delle nostre braccia.
Non ho per nulla paura di morire, ma ho paura di continuare ad uccidere. Da quando mi hanno strappato le armi di dosso ho detto “basta!”. Basta col sangue, basta con l’uccidere, basta con l’odio, basta con la guerra.
Ma la guerra continua. I partigiani di Tito e i tedeschi combattono a qualche chilometro da Spalato. Ma io attendo. Attendo soltanto. Chi? Che cosa? Non so. So solo che le ultime mie speranze muoiono, spente dal vento della più ossessionante bufera di fuoco, tra orizzonti, che pur noti, pare che per la prima volta delimitino il cerchio dei monti e del mare, che hanno anch’essi il volto di chi ho visto morire.
Era il 27 settembre del 1943. Dopo pochi giorni di disperata resistenza i militari italiani vennero fatti prigionieri dall’esercito tedesco. Fucilati tutti gli ufficiali, gli altri trasferiti nel campo di “smistamento” di Mappem. Qui, quanti si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò, continuarono il loro viaggio verso il nord della Germania. Un numero al posto del nome: 108130 quello di Domenico Ferraro.
Dakau-Dora, Wietzehdorf, Hausen, Buchenwald e Aachen. Due anni fra campi di concentramento e campi di lavoro. Poi il 9 ottobre del 1945 la fuga. Il rientro in patria e il solo, unico desiderio di dimenticare tutto.