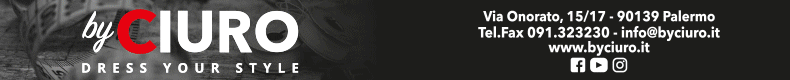Dal recupero alla valorizzazione. Ma soprattutto la fruizione e l’inserimento all’interno dei circuiti turistico-naturalistici. Il caso della sughereta di Geraci Siculo e Castelbuono racconta un successo tutto siciliano. A Geraci Siculo, il borgo verde delle Madonie, è stato presentato il progetto “Interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in zona speciale di conservazione ITA020020 – Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono”, finanziato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2014–2020 (Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework – PAF – e nei piani di gestione della Rete Natura 2000”). Il convegno, che si è tenuto al convento dei Padri Agostiniani, ha visto la presentazione dei risultati di anni di lavoro con esperti del settore e docenti universitari, in una sala gremita.
“Il recupero della nostra sughereta è un progetto molto importante – dice il sindaco di Geraci, Luigi Iuppa – perché, insieme alla nostra montagna, rappresenta uno degli elementi più significativi del territorio. Non sono stati eseguiti soltanto interventi fitosanitari, ma anche lavori che permettono la fruizione di questo patrimonio boschivo. Un’iniziativa che può essere replicata anche fuori dalla nostra regione”. La prima parte del progetto ha riguardato un intervento molto ampio, sul 40 per cento del totale della sughereta di Geraci e Castelbuono, finalizzato alla sua tutela e salvaguardia. “Le sugherete non sono importanti solo per la biodiversità del comprensorio madonita – aggiunge il primo cittadino – ma sono anche fonte di reddito e un grande polmone verde”.
Il progetto di recupero nasce dalla constatazione che diverse sugherete delle Madonie sono interessate da problemi fito-sanitari, in particolare sono diffusi due emiparassiti appartenenti alla famiglia delle lorantacee (vischio e loranto), la cui azione interessa in media il 50% delle sughere. Gli interventi nella sughereta di Geraci Siculo sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Gestione della ZSC ITA020020, con priorità alla tutela della biodiversità, alla protezione dei suoli e alla promozione dei servizi ecosistemici. A spiegare nel dettaglio gli interventi è Vincenzo David, agrotecnico: “L’azione principale del progetto è stata finalizzata alla riduzione degli attacchi di “vischio” a carico delle piante di sughera – spiega David – un arbusto emiparassita che, attaccandosi ai rami delle querce da sughero, ne ricava acqua e nutrienti, compromettendo le condizioni vegetative. A tal fine sono state effettuate anche potature e tagli mirati, asportando dalle chiome delle sughere i rami colpiti dai parassiti; le superfici di taglio sono state poi disinfettando le ferite con solfato ferroso e coprendole con apposito mastice di chiusura scuro, per evitare il ricaccio degli emiparassiti. Successivamente si è proceduto al decespugliamento delle aree di intervento, alla messa in opera della recinzione dell’intera sughereta e alla realizzazione di un’area didattica accessibile a tutti. Infine, è stato ricostruito il vecchio canale che porta l’acqua dalla sorgente fino alle vasche di raccolta, a supporto degli allevatori della zona”.
“Gestire i boschi in maniera sostenibile è fondamentale – sottolinea Donato La Mela Veca, docente di selvicoltura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo – L’abbandono colturale delle sugherete aumenta la frequenza di disturbi naturali che possono portare al loro deterioramento irreversibile. Tutti noi conosciamo l’importanza di un bosco per la vita sul pianeta, non solo per le piante, ma anche per l’integrità del territorio. I boschi ci aiutano a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, prevengono il dissesto idrogeologico e devono essere mantenuti in salute. Ma bisogna farlo in modo corretto, con una gestione sostenibile e pianificata”.
“Le sugherete sono fondamentali per molti aspetti – aggiunge Tommaso La Mantia, docente dello stesso Dipartimento –. Non parliamo solo degli aspetti economici, legati alla produzione del sughero, ma anche di quelli naturalistici ed ecologici. Sono considerate habitat, anche se si tratta di formazioni artificiali create dall’uomo. Occorre, dunque, una gestione corretta, perché una sughereta abbandonata diventa molto spesso una sughereta bruciata. E questo, purtroppo, lo leggiamo spesso nelle cronache nazionali. Il valore di una sughereta può essere salvaguardato solo attraverso una manutenzione e una gestione attente”.
A spiegare cos’è una sughera interviene Andrea Laschi, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo: “Si tratta di una quercia, una pianta mediterranea che ci regala questo materiale così particolare: il sughero. È una corteccia che si è evoluta nel corso del tempo per proteggere l’albero dalle avversità tipiche dell’area mediterranea, come il fuoco. È un materiale prezioso da secoli, utilizzato per diverse produzioni: la più nota è quella dei tappi, ma viene impiegato anche per pannelli isolanti, oggettistica e persino abbigliamento, perché è un materiale naturale e rinnovabile”.